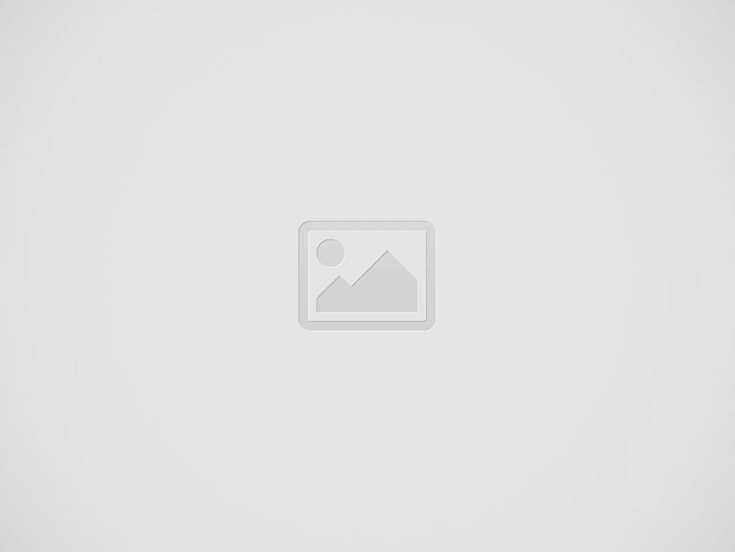

Storie ben scritte. “La capacità di raccontare delle storie, proprio in un mondo altamente tecnologico e interconnesso come il nostro, è diventata – ha spiegato – una delle più rilevanti competenze che possono arricchire una persona, ma anche la forza di un intero gruppo sociale, di un complessivo sistema-Paese”. Da Hollywood ad Al Jazeera, passando per le serie tv coreane, i manga giapponesi e i film dell’industria indiana, per determinare “le caratteristiche e i contenuti veicolati da grandi media come il cinema e la televisione” occorre focalizzarsi sulla cosiddetta “media élite”. La quale è “in una certa misura” determinata da “dimensioni economiche di bilancio”, ma è prima di tutto il frutto “delle scelte libere, degli orientamenti culturali, della sensibilità degli autori e dei dirigenti che si muovono in questa industria”. Dove in fondo “i soldi contano meno di quello che molti pensano”: alla fine, “sono i creativi a decidere con molta più autonomia e libertà di quello che non si creda, e le storie funzionano quando dicono cose vere e profonde”. Forse possono pure mentire sui contenuti che veicolano, ma non possono prescindere “dall’essere scritte bene”.
Vicini all’uomo comune. Se le connessioni tra il mondo dell’entertainment e quello politico si rivelano “molto più strette di quanto fosse immaginabile”, la tv non è, per Fumagalli, “una finestra sulla realtà ma sempre un discorso, in cui viene dato spazio ad esempio alla vita urbana e metropolitana piuttosto che a quella rurale, e di qui il conseguente spazio concesso, ad esempio, all’accentuazione della disgregazione della famiglia”. Per l’industria cinematografica americana si può parlare, ad esempio, “di un vero e proprio oligopolio”, con “fortissime barriere all’entrata”, di natura economica, professionale e legislativa. Ciononostante, la “forza principale del cinema hollywoodiano” è rimanere “vicino ai valori dell’uomo comune: i film di successo sono tutti a favore della libertà del singolo contro l’oppressione di sistemi totalitari, a favore della speranza in un mondo migliore, dell’uguaglianza degli uomini di fronte alla legge, contro il razzismo e per l’unità della famiglia umana”.
Tendenze a confronto. Per garantire alle aziende un minore rischio d’impresa, l’industria culturale americana ha col tempo “formalizzato l’esternalizzazione, per cui i professionisti sono dei freelance” che impiegano “il 70% delle energie nelle attività di politics, ossia nel convincere gli altri della qualità del proprio lavoro, nella creazione di contatti e nelle pubbliche relazioni: si tratta della tessitura dell’autodifesa e della self-promotion”. Quanto all’Italia, l’industria culturale “si sta internazionalizzando e professionalizzando”, basti pensare che “negli ultimi dieci anni il cinema italiano ha conquistato spazio e incassato di più, rappresentando nel 2011 il 37% del mercato mondiale: un risultato impensabile quindici anni fa”. Tra le ragioni di questa fioritura, il risveglio degli enti locali, il decreto Urbani del 2004 che, riducendo la quota di finanziamento dall’80 al 50% ha comportato la partecipazione di investitori, la nascita di società cinematografiche legate a Rai e Mediaset e il fatto che “molti professionisti oggi impegnati nel cinema si sono fatti le ossa in tv, imparando a raccontare una storia per un pubblico vasto”.
II limiti della cultura made in Italy. Ad affliggere il cinema italiano, alcuni “limiti”: che possono risiedere nella scelta del tema e della sua universalità, nell’ideologia “fortemente contraria all’happy end”, una vera e propria “chiusura di principio”, questa, che rischia “di rendere spesso frustrante la visione stessa del film”. Ancora, la “mancanza di vicinanza all’uomo comune e alla sua sensibilità”, nonostante un allargamento di “orizzonti, target e professionalità coinvolte”. Quanto al fruitore, per Fumagalli “deve rispondere al discernimento, andare a cercare cose buone, che ci sono, forse al cinema più che in tv, ma esistono. Non bisogna limitarsi a fare critica dei media, ma costruirla”.
Il bene è coinvolgente. Del fatto che “nei diversi ambiti il pubblico generalista conta sempre di più, e questo innesca un procedimento virtuoso per cui il prodotto funziona se vicino alla gente e a contatto con tematiche universali” ha parlato Bruno Mastroianni, docente di Media relations all’Università della Santa Croce: “Nel connubio tra economia e contenuti adatti a un largo pubblico – ha detto – riscuote successo la storia che parla di amicizia, eroismo, onestà”. Sul fruitore medio, che “non deve per forza andare a vedere il cinepanettone”, pesa un “pregiudizio che si concretizza se consideriamo il pubblico in senso astratto, ma non se il pubblico è quello vero: la famiglia, la provincia, dove alcuni valori sono attaccati e radicati”. Esiste, secondo Mastroianni, “un modo di arrivare al largo pubblico pur mantenendo la qualità dei temi: il fruitore, dal canto suo, deve scoprire il suo potere”. Se la famiglia, in questo senso, “è il pubblico più ambito in assoluto”, è proprio in casa, ma anche a scuola e in parrocchia, “che i ragazzi vanno educati ad essere pubblico, a fruire di beni all’altezza di uomini e donne completi. La storia buona – conclude – non è per forza a lieto fine: anche contrasti incredibili si sciolgono con il bene, che risulta sempre coinvolgente”.
