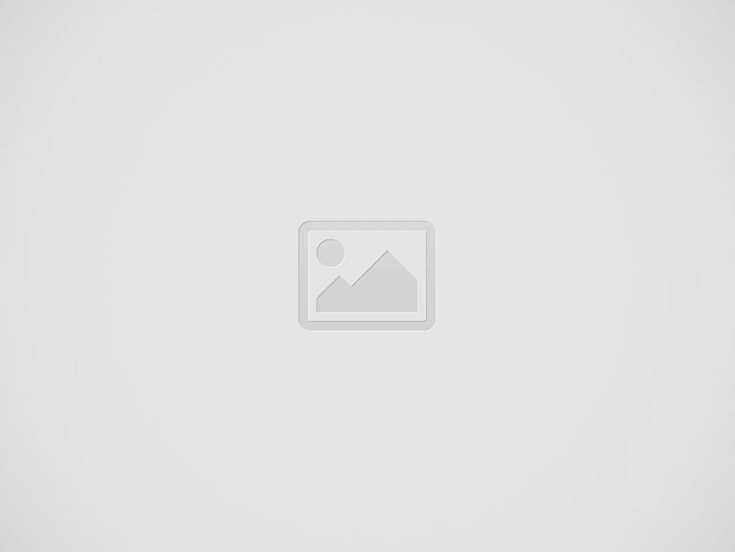I monti dell’Anti-Libano, ricoperti dalle nubi, sono così vicini che sembra quasi si possano toccare con una mano. Ibrahim li guarda spesso dalla sua tenda nel campo “Cesar 1”, a Zahle, capoluogo del Governatorato della Bekaa e dell’omonima valle, a circa 45 km a est di Beirut.
La città, la quarta del Libano, è nota anche come “la città del vino e della poesia” per i suoi ottimi vini e per i numerosi poeti che vi sono nati. Ma di poesia nel campo non se ne respira. Dietro quei monti così vicini c’è la Siria. Ibrahim è uno dei tanti rifugiati siriani – le stime parlano di circa 1,5 milioni, vale a dire il 30% della popolazione libanese – riparati in Libano per sfuggire alla guerra giunta ormai all’ottavo anno (15 marzo 2011). Prima del conflitto arrivare in auto da Zahle a Damasco “era quasi una passeggiata, oggi – dice – è impossibile. Non si passa più. Tutto sigillato”. Segnato dall’esperienza dei campi profughi palestinesi aperti dal 1948, dopo la proclamazione dello Stato di Israele, e ancora in piedi, il Libano non ha permesso la creazione di campi legali per i rifugiati siriani che hanno a loro volta improvvisato dei veri e propri accampamenti di fortuna, detti “informali” dalle stesse istituzioni libanesi. Secondo diversi organismi come Croce Rossa e Caritas Libano in tutta la valle ci sarebbero oggi qualcosa come 1900 campi “informali” dove vivono circa 800mila persone. Per questi rifugiati la Bekaa è diventata una terra di mezzo, una di quelle periferie umane dove si consuma lo scontro tra bene e male, dove può nascere o morire la speranza.
“I campi informali – spiega Ramzi Abou Zeid, coordinatore di Caritas Libano delle operazioni per i rifugiati – nascono su terreni affittati dagli stessi profughi. Molti di loro conoscono già la zona per averci lavorato prima della guerra. In poco tempo si tirano su le prime tende e baracche e il campo prende forma divenendo così un luogo di accoglienza comunitario dove si ritrovano interi gruppi familiari o persone della stessa provenienza. Tra gli abitanti del campo viene scelto lo ‘chawich’, parola di derivazione ottomana che vuol dire capo, leader. A lui spetta fare da tramite tra i rifugiati, le ong e le Nazioni Unite, tenere i contatti con le autorità locali libanesi, monitorare e comunicare settimanalmente le presenze alla polizia, tenere il registro dei residenti nel campo”.
Ibrahim viene da Raqqa, la città sirianache prima di essere liberata era la capitale dello Stato Islamico ed è lo “chawich” del campo “Cesar 1”: poco più di 60 tende occupate in media da una o due famiglie, per un totale di 600 rifugiati da tutta la Siria, moltissimi dei quali sono giovani e bambini. Sposato, con tre figli, è arrivato a Zahle alla fine del 2013 “per sfuggire – racconta – alla guerra e alla povertà. Qui nel campo non abbiamo acqua corrente, le condizioni igieniche sono disastrose”. L’energia elettrica viene garantita in qualche modo da allacci e fili volanti che alimentano le tante parabole che spuntano dai tetti di lamiera. “Ma meglio l’instabilità da profugo che la morte” sentenzia Ibrahim. La pioggia dei giorni precedenti ha trasformato i viottoli del campo in rivoli di fango dove le macchine che entrano e escono slittano spargendolo ovunque. Sono giornate fredde e le donne cercano di scaldare le tende con delle stufette o del fuoco. Fuori, seduto su sedie di fortuna, c’è chi cerca di catturare un po’ di tepore stando al sole. Si brucia tutto ciò che capita, soldi per comprare legna non ce ne sono molti.
Nonostante tutto al “Cesar 1” si cammina tra gli occhi curiosi degli anziani che ti si fanno incontro per stringerti la mano e salutarti e i sorrisi e le grida dei bambini, che ti girano intorno divertiti. Passano il tempo libero dalla scuola giocando con quello che capita loro tra le mani o inseguendo le galline tra le tende. Molti sono piccolissimi. I più fortunati hanno ai piedi delle vecchie scarpe ma c’è chi calza solo delle ciabatte o addirittura cammina scalzo. “Ahlân wasahlân!”, benvenuti!, “sħukrân”, grazie!, ripetono in continuazione. Ibrahim invita a sedersi e racconta di una vita nel campo che “scorre lenta. Al mattino gli uomini e i più giovani escono per lavorare. La gran parte sono impegnati nel campo agricolo ed edile, (gli unici due settori, con quello ambientale, nei quali è concesso ai rifugiati di lavorare legalmente, ndr). A sera, prima che faccia notte rientrano tutti”. Anche Ibrahim lavorava come muratore prima di essere costretto a lasciare l’occupazione per motivi di salute. Oggi sbarca il lunario collaborando con Caritas Libano e altre ong all’interno del campo. Ma con quale futuro?
“La speranza più grande per chi vive qui al campo – spiega Ibrahim – è quella di partire per gli Usa, il Canada, l’Australia o l’Europa. L’alternativa sarebbe restare in Libano”. Tornare in Siria? “E a fare cosa? È stato tutto distrutto, non c’è motivo per tornare. Questa è la triste realtà di oggi” dice desolato mentre cammina verso l’uscita del campo. Poi si ferma un attimo e si volta. È a questo punto che la sua voce riacquista tono. “Se guardo questi monti così vicini e penso che a pochi chilometri c’è il mio Paese mi si spezza il cuore. E allora dico chissà se davvero un giorno… Sì, sì.. C’è sempre speranza di tornare, ‘Inshallah’, se Dio vuole”.