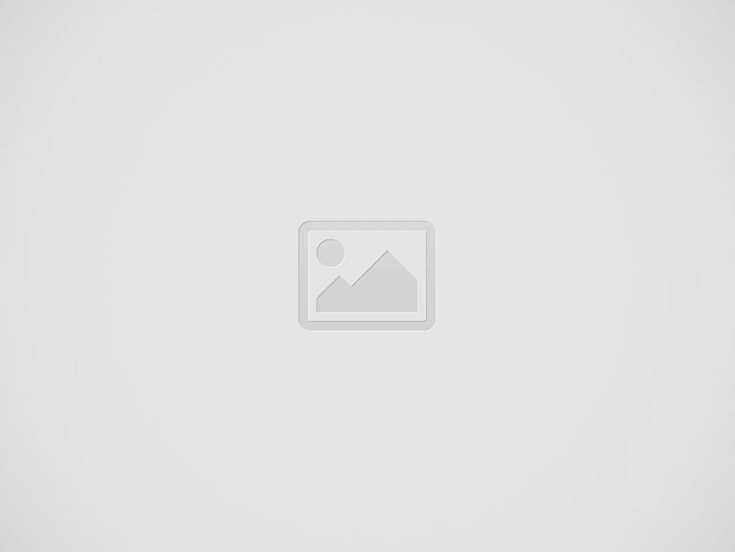

SAN BENEDETTO – La professoressa Elisa Vita, dirigente del Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto del Tronto, esplora le sfide educative contemporanee e l’importanza di un’alleanza forte tra scuola, famiglia, parrocchia e società. Un’intervista in cui si affrontano temi cruciali come il cambiamento del ruolo dei genitori, la fragilità dei giovani e la necessità di una guida educativa autorevole.
In che modo si può ricostruire un’alleanza educativa tra scuola, parrocchia, famiglia e società? Quali strategie possono favorire questa sinergia?
L’alleanza educativa non è qualcosa da “ricostruire”, ma piuttosto un processo che deve adattarsi ai cambiamenti della società. Occorre trovare nuovi modi di interazione che coinvolgano scuola, famiglia, parrocchia e società. Non esistono strategie preconfezionate, ma se coesistono apertura e dialogo onesto si giungerà sempre a una soluzione condivisa.
Come è cambiato il ruolo dei genitori negli ultimi anni? In che modo le nuove difficoltà incidono sulla loro capacità educativa? Si nota un prolungamento dell’adolescenza anche tra gli adulti?
È la società ad essere cambiata, naturalmente. I giovani chiedono nuovi bisogni, manifestano altri desideri e assimilano nuovi sistemi di valori; talvolta sono delusi e mostrano incertezza verso il futuro. Tutto questo richiede una diversa chiave di lettura. Sono nati in un contesto culturale di profonda crisi, ma caratterizzato anche dall’evoluzione tecnologica e per questo comunicano attraverso immagini e video. Dunque, i genitori devono comprendere e adattarsi a questo cambiamento e rappresentare sempre un punto fermo imprescindibile nella vita dei figli. Questo è il motivo per cui il rispetto della loro autorità è ancora importante. In realtà, devono semplicemente “fare” i genitori come hanno fatto i nostri prima di noi. È il riconoscerne l’autorità, intesa non come una questione di “potere”, ma di responsabilità. Si tratta di chiarire il proprio ruolo. Il genitore è un modello da seguire e imitare attraverso esempi di onestà, coerenza e tanto amore. Contano il confronto, talvolta i compromessi degli uni e le rinunce degli altri, elementi fondamentali nel processo di crescita.
Qual è la percentuale di famiglie separate nella comunità scolastica? In che misura questo influisce sul percorso educativo degli studenti?
La separazione dei genitori è sempre un evento traumatico per i giovani, che vedono improvvisamente sconvolta la loro quotidianità. Questo cambiamento non può non influire sul percorso educativo, creando incertezze emotive e difficoltà psicologiche, come senso di colpa, rabbia, tristezza, paura e ansia. I ragazzi imparano che le relazioni possono essere fragili e che certe situazioni sono fuori dal loro controllo. Occorre, dunque, trovare un nuovo equilibrio con un linguaggio chiaro che definisca il problema e lo affronti. La scuola è ancora una volta chiamata a dare una risposta adeguata e questo è possibile soltanto con un lavoro quotidiano e costante basato sul dialogo, sulla fiducia e sull’attesa di un adattamento a una nuova normalità.
Si osserva un aumento della fragilità nei giovani? Quali sono i principali segnali di questa tendenza?
Fragilità è un termine che ricorre spesso, soprattutto se si parla di giovani. In realtà, la fragilità in età evolutiva è una condizione connaturata, perché l’adolescente non ha ancora strutturato le competenze che gli servono per padroneggiare l’esperienza; competenze che acquisirà proprio con la stessa esperienza e con la guida e il supporto degli adulti di riferimento, genitori e insegnanti. Fragilità, dunque, non deve essere un’etichetta, bensì una potenzialità. La scuola è il luogo fondamentale per sperimentare le proprie fragilità e i docenti sono figure essenziali per il superamento di questa condizione e la sua evoluzione positiva. Altrimenti subentrano scarsa stima di sé, sfiducia nelle proprie capacità e negli altri, senso di inadeguatezza, frustrazione, indolenza e, infine, abbandono scolastico. La scuola ha il dovere di evitarlo attraverso prevenzione, interventi personalizzati e riduzione del divario formativo, socio-economico e culturale. È una sfida che presuppone un impegno concreto: è e sarà sempre soltanto attraverso una guida sicura, una relazione educativa efficace tra docente e studente, fiducia incondizionata, motivazione e prassi condivise, partecipazione attiva e ascolto, che si potrà giungere alla scoperta della propria unicità per costruire in modo autentico il proprio percorso di crescita, elemento imprescindibile per il successo formativo degli studenti e per la piena realizzazione di sé e del diritto allo studio.
I giovani di oggi sono realmente diversi dalle generazioni precedenti o hanno semplicemente bisogno di guide autorevoli e di riferimento?
I giovani sono sempre giovani, con le stesse fragilità e le insicurezze che abbiamo vissuto anche noi. Quello che è cambiato è il contesto sociale. Hanno bisogno di guide autorevoli e di un punto di riferimento stabile. I genitori e gli insegnanti devono essere modelli di riferimento, seguirli nel percorso di crescita, lasciare loro la libertà di pensare e di sbagliare, ma sempre con il supporto necessario per affrontare le difficoltà. La bellezza del ruolo educativo e genitoriale è proprio questa: fare in modo che i giovani scoprano la loro strada, imparando dai propri errori e vivendo in un ambiente che li sostiene nelle cadute e alla fine nei successi, che sicuramente si realizzeranno.
