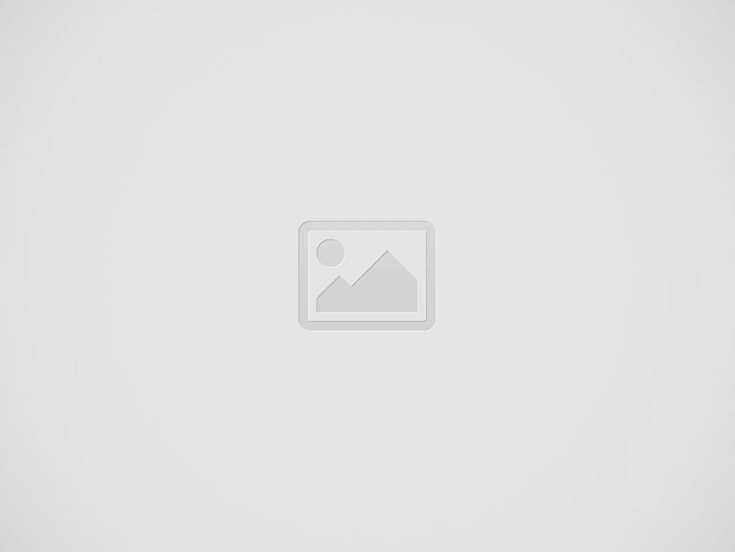

Giovanna Pasqualin Traversa
“La sofferenza che si è fatta presente nell’ultima parte della mia vita l’ho offerta al Signore per la pace nel mondo e la fratellanza tra i popoli”. Così Papa Francesco ha concluso il suo testamento. E nel messaggio Urbi et Orbi di domenica 20 aprile, giorno di Pasqua, ha auspicato: “Vorrei che tornassimo a sperare che la pace è possibile”, precisando tuttavia che “nessuna pace è possibile senza un vero disarmo”. Pace, fratellanza tra i popoli, disarmo dalle armi e dei cuori sono parole chiave del suo pontificato. Quale può essere un primo bilancio a caldo della visione geopolitica di Papa Francesco? Lo abbiamo chiesto a Vincenzo Buonomo, professore di diritto internazionale alla Pontificia Università Lateranense.
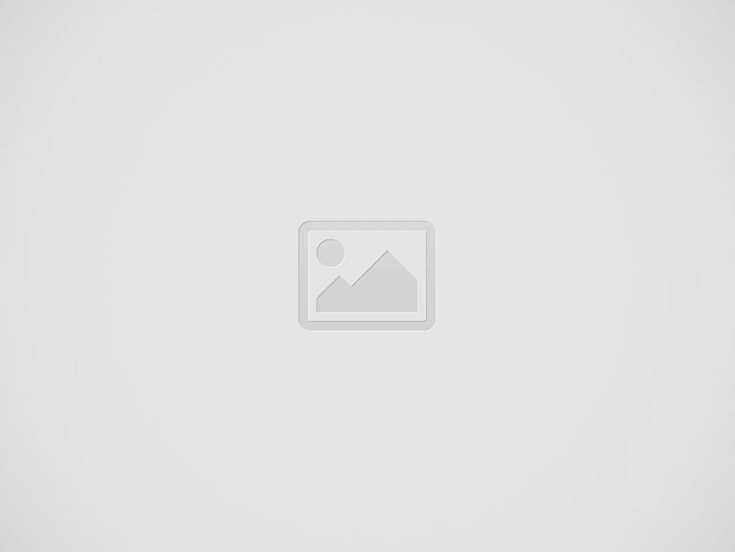

(Foto Siciliani – Gennari/SIR)
“Guardando ai suoi interventi sul piano internazionale o relativi a questioni di carattere internazionale – esordisce Buonomo -, emerge un filo conduttore che trova il suo compimento proprio nel messaggio Urbi et Orbi della domenica di Pasqua. L’idea, cioè, che
la pace è nel cuore degli uomini.
Lo sostenne già nel 2013, appena eletto, incontrando il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede e indicando i tre elementi che potevano concorrere a creare la pace: lo sviluppo, la stabilità e la sicurezza, il rispetto delle persone. Allo stesso tempo precisò che tutto partiva proprio dal cuore dell’uomo. Una convinzione ribadita in ogni incontro con le grandi organizzazioni internazionali: dal Consiglio d’Europa al Parlamento Ue fino all’Onu, e nel corso dei viaggi apostolici. L’idea del Papa è quella non di una pace costruita sulla base di tecniche o di un’attività diplomatica, ma di una pace che nasca dal basso”.
Una tesi che viene sistematizzata nell’enciclica Fratelli tutti…
In questo documento il Papa ha posto in dottrina quanto enunciato in diverse occasioni: l’architettura della pace, che è frutto di una serie di situazioni, ma anzitutto frutto del lavoro degli artigiani della pace, e chiama ciascuno di noi, in prima persona, ad essere proprio artigiani di pace.
Francesco non si è mai stancato di ribadire la necessità di un requisito essenziale: il disarmo, nucleare, dalle armi tradizionali e dei nostri cuori.
E’ il disarmo dei cuori ad avere un effetto positivo sul disarmo degli armamenti.
Foto Calvarese/SIR
In questo ambito, la stessa dottrina della Chiesa in materia di guerra e uso delle armi ha compiuto con il Papa dei passi avanti. Nel suo discorso a Hiroshima, il 24 novembre 2019, affermò con chiarezza che
non solo è immorale l’uso delle armi atomiche, ma lo è anche il loro possesso,
superando così quanto affermato nel Catechismo della Chiesa cattolica.
“Non venga mai meno il principio di umanità come cardine del nostro agire quotidiano”, l’auspicio del Pontefice il giorno di Pasqua…
Francesco ha fatto esplicito riferimento al mancato rispetto dei principi che hanno caratterizzato la civiltà umana rispetto al tema della guerra, applicandolo a quattro situazioni concrete: il conflitto Ucraina-Russia, denunciando che gli obiettivi civili sono diventati obiettivi militari; la situazione spaventosa che sta vivendo la popolazione civile a Gaza; il conflitto in Myanmar dove si è addirittura arrivati ad un’accettazione selettiva degli aiuti durante il terremoto; infine il conflitto nel Sud-Sudan e le violenze nel Corno d’Africa. Il Papa parla di pace partendo dalla guerra. Ricordo ancora il discorso al sacrario di Redipuglia nel 2014, in occasione del centenario dello scoppio della Prima guerra mondiale, nel quale affermò che ognuno di noi ritiene che la responsabilità di un conflitto non sia sua, ma degli altri, in base al principio disumano ‘a me che importa’, aggiungendo che oggi si può forse parlare di ‘una terza guerra mondiale a pezzi’”.
(Foto ANSA/SIR)
Un Papa dirompente fin dall’inizio, con la scelta di Lampedusa come meta del suo primo viaggio apostolico, l’8 luglio 2013, che ha dato già da allora la cifra di un pontificato dalla parte dei poveri, degli ultimi, schierato contro la globalizzazione dell’indifferenza. Francesco ha ampliato gli orizzonti geopolitici della Chiesa?
Ha soprattutto inaugurato la stagione di una Chiesa pronta non ad occupare spazi, ma ad avviare processi,
come afferma fin dal 2013 nel documento programmatico del suo pontificato, l’Evangelii gaudium. Di qui anche la definizione di Chiesa come ospedale da campo, che concorre con le altre forze vive della società per poterla costruire o ricostruire.
In particolare, il Papa ha ampliato la capacità della Chiesa di porsi di fronte alle grandi questioni,
non soltanto per una lettura/valutazione delle situazioni, ma per poter operare concretamente.
Partendo dal basso…
Sì, questo è il suo approccio, dove il “basso” significa non soltanto il livello del popolo, ma, all’interno di quel livello, indica gli emarginati, gli ultimi. Non è retorica del pauperismo, come talvolta è stata interpretata, ma una concreta metodologia per affrontare le grandi questioni.
Ad esempio?
Con riferimento alla guerra, chiedersi chi siano le persone che ne subiscono gli effetti più devastanti. Certamente non i produttori di armi o coloro che addestrano i droni, ma i più poveri, coloro che non possono lasciare le case o i villaggi in cui vivono. Così per i disastri ambientali: ne sono vittime soprattutto i popoli indigeni, le minoranze, i gruppi etnici ristretti.
(Foto AFP/SIR)
Il Papa non si è mai stancato di lanciare accorati appelli per la pace, ma talvolta le sue parole sono state male interpretate o addirittura strumentalizzate, come quelle sul “genocidio” a Gaza…
Il Pontefice aveva ben in mente che cosa significhi il genocidio. A differenza di quanto affermato da alcuni, il Papa non ha mai sostenuto che a Gaza si stesse verificando un genocidio, ma che occorrerà accertare – e questo di norma lo si fa nel post-conflitto – se alcuni dei comportamenti perpetrati nella Striscia possano essere identificati come genocidi. Francesco ha spesso usato espressioni forti, di grande impatto, ma sempre in modo appropriato e coerente con un pensiero che non si limita alle parole.
Purtroppo la strumentalizzazione è utile per chi cerca giustificazioni all’uso della forza e della violenza.
Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, il 25 febbraio 2022 il Papa si è recato a sorpresa all’ambasciata russa presso la Santa Sede, e tra il 2023 e il 2024 ha affidato al card. Matteo Zuppi, presidente della Cei, una missione di pace che ha toccato Kiev, Mosca, Washington e Pechino, con obiettivi ben precisi e, secondo alcuni, risultati modesti…
Il ruolo che la Santa Sede ha svolto e continua a svolgere è di tipo umanitario e si è concretizzato nel ritorno in Ucraina dei bambini che erano stati sottratti alle proprie famiglie e portati forzatamente in Russia, e nello scambio dei prigionieri; l’ultimo anche il giorno di Pasqua.
(Foto ANSA/SIR)
L’azione della Santa Sede è finalizzata alla facilitazione del dialogo e al cosiddetto post-conflitto, cioè al tentativo di individuare i canali attraverso i quali formare delle generazioni ad un nuovo scenario di possibile coesistenza.
Il conflitto esploso nel febbraio 2022 si era acceso nel 2014 e già in quell’occasione il Papa aveva assunto posizioni molto nette nei confronti di quanto stava avvenendo nel Donbass. Ha seguito l’evolversi della situazione e il suo gesto di recarsi dall’ambasciatore della Federazione russa dimostra il desiderio di risolvere i conflitti attraverso il negoziato, non una semplice mediazione, ma attraverso un negoziato mettendo tutte le parti intorno ad un tavolo senza escludere nessuno. La celebre frase ‘la pace si fa con il nemico’, Papa Francesco l’ha incarnata proprio in questo modo, esponendosi personalmente, proprio come Francesco d’Assisi che non ebbe paura di recarsi dal sultano.
Che eredità ci lascia da questo punto di vista?
Ci lascia un metodo per le relazioni internazionali, basato come dicevo prima, non soltanto sulla lettura delle situazioni, ma soprattutto sul comprenderne le tendenze, gli sviluppi e la visione verso cui si sta procedendo. Interpretare i fatti e capire che i comportamenti di oggi avranno una sostanziale ricaduta nel medio e lungo periodo. Con coraggio profetico,
Francesco ha inoltre rilanciato il multilateralismo e aperto nuove vie di dialogo all’insegna della fraternità che può accomunare il cuore di ogni uomo, credente o non credente.

