
Si è appena concluso il Giubileo degli adolescenti, una fascia di età che era molto cara a Papa Francesco. Negli ultimi anni i giovanissimi hanno mostrato di essere bisognosi di rinnovata attenzione. Proprio per rispondere alle tante esigenze di questa fascia di età è nata la Società italiana di medicina dell’adolescenza (Sima). Abbiamo parlato con la sua presidente, Rossella Gaudino, sulle problematiche che affliggono oggi i ragazzi.

(Foto: Sima)
Perché è necessaria una Società italiana di medicina dell’adolescenza?
La necessità di una Società italiana di medicina dell’adolescenza nasce da specificità biologiche, sociali e assistenziali legate a questa fascia d’età. Storicamente, l’adolescenza è stata a lungo trascurata in ambito medico, considerata semplicemente una fase di transizione tra infanzia ed età adulta. Tuttavia, l’anticipazione dello sviluppo puberale e le peculiarità neuropsicologiche degli adolescenti hanno reso evidente l’esigenza di un approccio medico specializzato e sempre più formato. Gli adolescenti richiedono specificità cliniche, le loro patologie e le cause di morbilità/mortalità differiscono sia da quelle pediatriche sia da quelle adulte, pensiamo solo ad esempio ai disturbi del comportamento alimentare, al problema delle dipendenze o al disagio psichico che esordiscono proprio adolescenza.Questa età fragile necessita di una formazione specialistica e di competenze multidisciplinari certificate, poiché i tradizionali percorsi di pediatria o medicina generale non coprono adeguatamente le esigenze psicosociali e biologiche degli adolescenti.
Perché oggi essere adolescente sembra essere più complicato che per le generazioni precedenti?
L’adolescenza oggi si configura come una fase della vita profondamente trasformata rispetto al passato, sia per effetto di cambiamenti socio-culturali sia per l’impatto delle nuove tecnologie.Questi mutamenti hanno generato nuove vulnerabilità e reso più complesso il percorso verso l’età adulta.
Devono affrontare le classiche sfide tipiche dell’età di transizione dall’infanzia all’età adulta, amplificate dal contesto moderno, o ce ne sono di nuove e inusuali?
Negli ultimi decenni, il percorso formativo degli adolescenti si è notevolmente allungato, con un prolungamento degli studi e un ingresso sempre più tardivo nel mondo del lavoro. In Italia, questa tendenza è particolarmente accentuata:si parla di “sindrome del ritardo”, con posticipazione dell’indipendenza economica e della formazione di una nuova famiglia, e tassi di occupazione giovanile inferiori rispetto alla media europea.Questo fenomeno, noto anche come “emerging adulthood”, espone i giovani a una fase di incertezza prolungata, caratterizzata da insicurezza economica, ansia e difficoltà di inserimento lavorativo.
Secondo lei perché ansia e depressione, comportamenti autolesionistici e suicidari, isolamento e difficoltà relazionali, disturbi del sonno sono così in aumento tra gli adolescenti?
Io ritengo sia dovuto ad una combinazione diversi di fattori complessi. In primo luogo, la pandemia da Covid-19 ha agito come un catalizzatore, accentuando la sofferenza psicologica attraverso isolamento sociale, perdita di routine, paura della malattia e lutti, che hanno aumentato ansia e depressione in modo significativo.Le trasformazioni sociali si intrecciano, inoltre, con l’impatto della tecnologia, che, se da un lato offre opportunità di apprendimento e connessione, dall’altro può favorire fenomeni di isolamento, ritiro sociale e iperconnessione. Queste condizioni compromettono lo sviluppo di competenze emotive, affettive e relazionali, aumentando il rischio di nuove fragilità e patologie adolescenziali.L’uso eccessivo di dispositivi digitali può portare a una perdita di contatto con la realtà sociale, difficoltà nelle relazioni interpersonali e una maggiore esposizione a dipendenze e disturbi come ansia e depressione. Vi sono infine cause biologiche e psicologiche, come alterazioni neurobiologiche, traumi psicologici e stress ambientali, che aumentano il rischio di disturbi depressivi e ansiosi. Anche tutti i cambiamenti ormonali e le sfide tipiche dell’adolescenza si sommano a questi fattori, rendendo ancora più vulnerabili i giovani. Come diceva Jean Piaget gli adolescenti “abitano una casa in costruzione”. Il loro stato cognitivo e fisico è ancora in costruzione con tutte le incertezze che comporta. Ha mai provato a vivere in una casa con i lavori in corso durante un trasloco? Un’impresa da vero eroe!
In aumento sono anche episodi che vedono protagonisti negativi e violenti gli adolescenti: in azione vediamo spesso baby gang o anche singoli capaci anche di omicidi. Come intervenire efficacemente in questo campo?
Per contrastare tali fenomeni in aumento è fondamentale intervenire con un approccio integrato che coinvolga famiglia, scuola e comunità.La prevenzione precoce, attraverso l’educazione ai valori, il supporto psicologico e l’offerta di opportunità educative e lavorative, aiuta a ridurre i rischi.In caso di comportamenti violenti, è importante intervenire tempestivamente con strategie di gestione della crisi e percorsi di giustizia riparativa, favorendo il reinserimento sociale e la responsabilizzazione dei giovani.
Come esperti della salute degli adolescenti, valutate la tecnologia e i social media più un’opportunità o un rischio per loro?
I social offrono indubbiamente opportunità di connessione, espressione creativa e accesso a informazioni utili, favorendo un senso di appartenenza e comunità. Dall’altro, un uso eccessivo o non regolato può aumentare il rischio di ansia, depressione, disturbi del sonno, bassa autostima e dipendenza comportamentale, soprattutto nelle ragazze, con effetti negativi sullo sviluppo psichico e sociale.È cruciale promuovere un uso consapevole e guidato, con limiti chiari e supporto educativo, per massimizzare i benefici e ridurre i danni alla salute mentale degli adolescenti.Il nostro congresso nazionale Sima che si terrà a Udine dal 25 al 27 settembre ha proprio come focus la salute mentale e le importanti connessioni tra mente e corpo per il benessere globale dei nostri giovani.
Cosa potrebbero fare di più istituzioni, società, agenzie educative contro i comportamenti a rischio quali uso di sostanze, disturbi alimentari, dipendenze da gioco d’azzardo o dal digitale, sfide o “challenge” online pericolose? Servono alleanze e reti?
Indubbiamente servono reti e alleanze in ogni ambito. Serve formazione e ricerca al fine di comprendere appieno quello che sta accadendo ai nostri giovani. Io ritengo fortemente che la chiave sia l’autostima. È stata condotta una recentissima e molto interessante revisione sistematica degli studi pubblicati nelle banche dati Web of Science, PsycInfo e Medline nell’ultimo decennio, con l’obiettivo di raccogliere studi sulla relazione tra autostima e comportamento a rischio in individui di età compresa tra 12 e 18 anni. L’obiettivo era quello di confermare il ruolo di un’elevata autostima come fattore protettivo costante contro i comportamenti a rischio. I risultati mostrano che l’autostima è correlata negativamente ai comportamenti a rischio. Questi risultati riflettono anche la necessità di ulteriori ricerche su come i fattori sociodemografici, tra gli altri, influenzano la relazione tra autostima e comportamenti a rischio. Questa revisione evidenzia l’importanza di attuare interventi educativi specifici per
rafforzare l’autostima negli adolescenti, con l’obiettivo di prevenire vari comportamenti a rischio
che possono emergere durante l’adolescenza ma persistere per tutta la vita.
Il Giubileo 2025 è stato dedicato da Papa Francesco alla speranza: come aiutare i nostri adolescenti a ritrovare speranza nel futuro?
Mi piace ricordare solo una delle dense frasi rivolte agli adolescenti da Papa Francesco: “I sogni sono importanti. Per favore, non perdere la capacità di sognare…”. Eppure, molti adolescenti, secondo studi recenti il 45% circa, mostrano un senso di incertezza e ansia riguardo al proprio futuro, con paure che possono rallentare lo sviluppo della loro identità e la capacità di progettare concretamente la propria vita.Per aiutarli a ritrovare speranza dobbiamo aiutarli a rafforzare l’autostima in ogni settore della loro giornata e vita.Tutti dobbiamo impegnarci a responsabilizzarli, permettendo loro di assumersi le conseguenze delle proprie azioni e sviluppare senso di competenza; incoraggiarli a fissare e raggiungere obiettivi realistici, celebrando ogni successo per rinforzare la percezione positiva di sé; favorire attività come sport e teatro, che aiutano a superare la timidezza, esprimersi e scoprire le proprie capacità; promuovere una mentalità positiva e inclusiva, sostituendo pensieri negativi con affermazioni costruttive e praticando l’auto-accettazione di sé stessi ma anche degli altri; offrire supporto emotivo e accettazione da parte di genitori, insegnanti e coetanei, fondamentali per sentirsi valorizzati e accettati; insegnare a gestire il fallimento come opportunità di crescita, non come un ostacolo insormontabile.
Lei pensa che possiamo “scommettere” su questa generazione?
Come mamma di due adolescenti (16 e 17 anni) e come medico, credo che “scommettere” su questa generazione sia non solo possibile, ma necessario, pur riconoscendo il profondo disagio che vivono. Molti giovani oggi affrontano una forte ansia anticipatoria legata proprio all’incertezza del futuro, con paure su scelte scolastiche, autonomia personale e aspettative sociali che possono indubbiamente rallentare lo sviluppo della loro identità. Questa paura è amplificata da un contesto socio-economico instabile, da un mercato del lavoro incerto e da un confronto costante sui social media che spesso alimenta il senso di inadeguatezza e isolamento. Tuttavia, questa fragilità non è segno di debolezza ma di una di una generazione che necessita di sostegno, ascolto e opportunità concrete per costruire fiducia in sé e nel futuro. Dunque,con il giusto accompagnamento e una società che offra punti di riferimento stabili, possiamo e dobbiamo credere nel potenziale di questi giovani, perché la loro energia e creatività sono risorse fondamentali per il domani. “I sogni dei giovani sono il futuro dell’umanità”, diceva Papa Francesco.




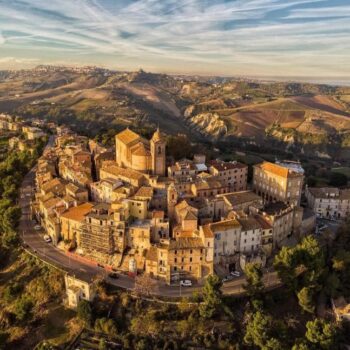









0 commenti